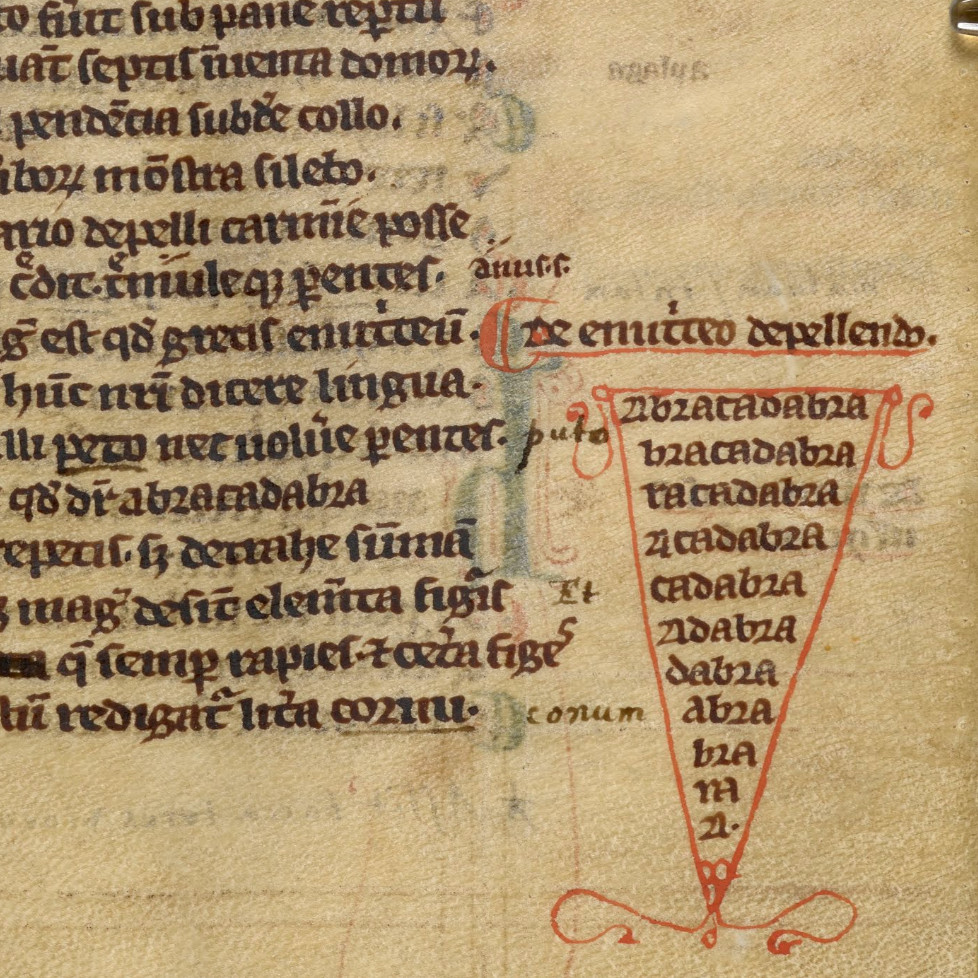Tradotto dal francese

Due passioni care a Nunc est bibendum – la cucina e il gioco – si incontrano su una pietra vecchia di venticinque secoli: la stele Peruzzi, oggi conservata alla Villa Corsini a Castello, vicino a Firenze.
Datata alla fine del VI o all’inizio del V secolo a.C., questa stele funeraria in pietra grigia di arcosio proviene da Varlungo, ad est della capitale toscana. Appartiene alla serie detta delle steli fiesolane, monumenti funerari caratteristici dell’aristocrazia etrusca di Fiesole. Sulla sua superficie trapezoidale si dispiegano due scene scolpite dove si esprimono la cultura e i valori di una società raffinata, gerarchizzata, profondamente legata al piacere del buon vivere.
Il banchetto: gerarchia e convivialità
Nella parte superiore, un banchetto: due uomini, sdraiati su una klinè, alzano le loro coppe, serviti da un coppiere in piedi.
Il vino, la convivialità e la gerarchie sociali si confondono, perché bere insieme significa più che condividere un pasto: significa affermare il proprio rango, celebrare l’appartenenza a un’élite e perpetuare un’arte di vivere dove il vino è anche simbolo di padronanza e misura.
Questo tipo di scena è frequente nell’arte funeraria etrusca: richiama lo symposion greco, il banchetto adottato e adattato dalle aristocrazie etrusche, che vi vedevano l’espressione del loro prestigio, della loro cultura e della loro appartenenza a un cerchio di uomini liberi.
L’ultimo tiro del giocatore
Sotto, un gioco da tavolo: due giovani seduti faccia a faccia, separati da un tavolino a tre piedi su cui riposa una tavoletta.
Uno di loro tende la mano – per lanciare un dado? Prendere un pedino? Il gesto rimane enigmatico.
Secondo l’archeologa e storica dell’arte etrusca Petra Amann, si tratta della sola scena conosciuta di gioco in tutto l’insieme delle steli fiesolane, un corpus di circa trenta monumenti rinvenuti nella regione di Fiesole, a nord-est di Firenze.
Il personaggio barbuto, leggermente più grande, rappresenterebbe senza dubbio il defunto stesso, opposto a un avversario o a un compagno di gioco.
Questo confronto frontale diventa più di un semplice divertimento: una metafora del rango, della padronanza e del destino.
Nella cultura etrusca, il gioco non era un passatempo banale, ma un segno di distinzione, un esercizio di strategia e misura, in cui la fortuna doveva essere sempre tenuta sotto controllo.
Qui, la partita sembra sospesa, come se il giocatore, sull’orlo della morte, stesse giocando la sua ultima mossa contro il destino.
Intagliate nell’arcosio grigio locale, queste steli fiesolane presentano quasi sempre due registri sovrapposti: banchetti, corteggi, conversazioni – tanti frammenti scolpiti della vita ideale dell’élite maschile.
L’ideale aristocratico etrusco
Queste due immagini, quella del banchetto e quella del gioco, condensano un unico ideale: giocare, banchettare, misurarsi nel piacere tanto quanto nel pensiero.
Tra gli Etruschi, questi gesti non erano semplici divertimenti: esprimevano uno status, un’educazione, una cultura del tempo libero nobile dove la misura, la strategia e la parola definivano il prestigio.

 Fonti e riferimenti
Fonti e riferimenti
Petra Amann, Le pietre fiesolane: repertorio iconografico e strutture sociali, in Cippi, Stele, Statue–Stele e Semata. Testimonianze in Etruria, nel mondo italico ed in Magna Grecia dalla prima Età del ferro fino all’Ellenismo, éd. S. Steingräber, Pisa, ETS, 2018, p. 63–79.
Danza e banchetto sulle stele funerarie felsinee, in Studi Etruschi (2014).
L’ombra degli Etruschi. Simboli di un popolo tra pianura e collina, dir. Paola Perazzi, Gabriella Poggesi, Susanna Sarti, Edifir, Firenze, 2016.
Altri articoli del blog Nunc est bibendum