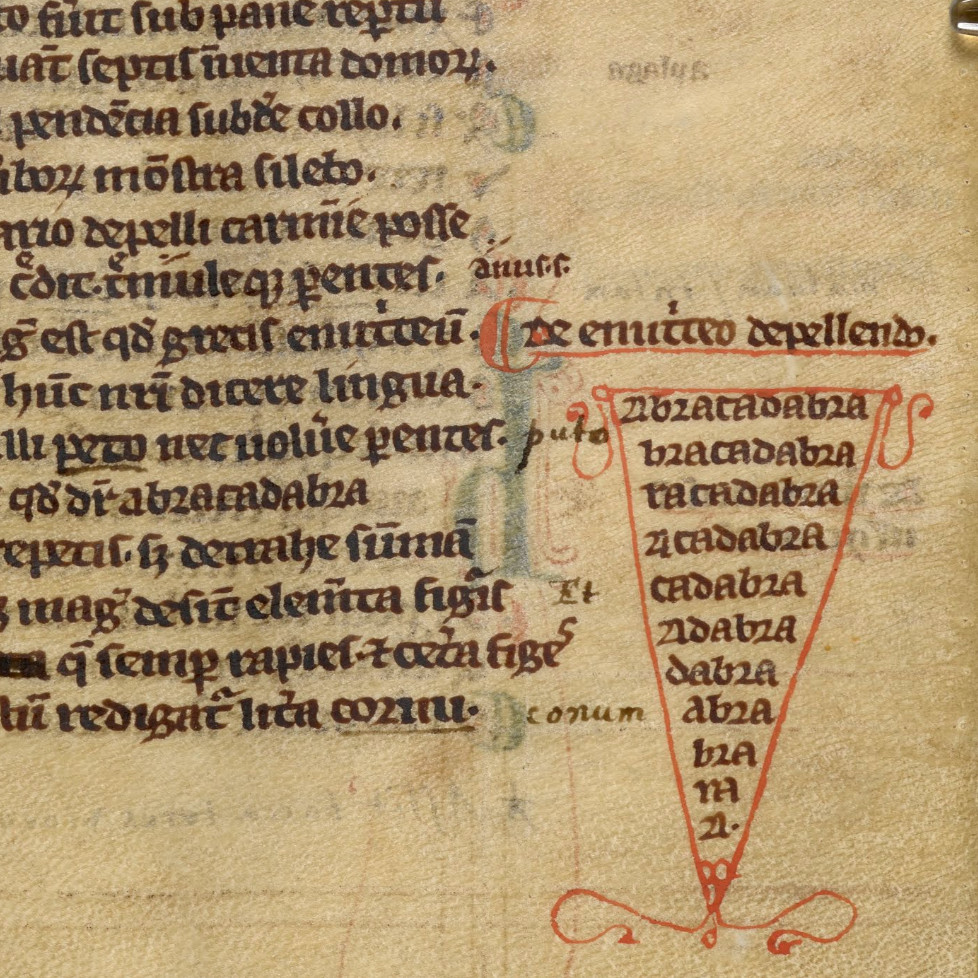Tradotto dal francese

Scoperta di un’importante quantità di droga nei Paesi Bassi! Nel 2017, gli archeologi che scavavano il sito di Houten-Castellum hanno fatto una scoperta insolita. In un pozzo romano risalente alla fine del I secolo della nostra era, si trovava un femore di pecora o capra accuratamente svuotato per formare un cilindro di 72 millimetri di lunghezza. Dietro il tappo di pece di corteccia di betulla, ovvero una sorta di catrame: 382 semi di giusquiamo nero, una pianta estremamente tossica della famiglia delle solanacee, come la belladonna o la mandragora.
I medici antichi conoscevano bene questa pianta e i suoi pericoli. Dioscoride, medico greco del I secolo, distingue tre tipi di giusquiamo.
Il primo “porta fiori quasi purpurei, foglie simili al smilace, un seme nero, e frutti duri e spinosi”. Il secondo ha “fiori giallastri, foglie e baccelli più teneri, e un seme di un giallo pallido come quello dell’iris”. Questi due tipi “provocano follia e sonno, sono difficili da utilizzare”. “Utile per le cure e molto dolce è il terzo”, che è “grasso, tenero e soffice, con fiori bianchi e un seme bianco”. Dioscoride raccomanda quindi di “utilizzare il bianco; ma se questo non è disponibile, bisogna utilizzare il giallo, ma respingere il nero come il peggiore”. I semi trasformati in succo alleviano “il dolore, i flussi acri e caldi, i mal d’orecchi e le affezioni della matrice”. Ma avverte che le foglie “bollite come verdure e mangiate in quantità di una scodella causano un turbamento moderato dei sensi”[1].
Nella sua Storia naturale, Plinio il Vecchio nomina quattro varietà di giusquiamo e avverte che “tutte causano follia e vertigini”[2]. Descrive tuttavia numerosi usi medici: il succo può essere applicato sui nervi[3], e il giusquiamo calma i tumori dei testicoli[4]. Una miscela di giusquiamo con latte d’asina aiuta contro “le flatulenze e l’affanno”[5].

Ma Plinio esprime delle riserve personali su questa pianta:
“In generale, l’uso di questa pianta è, secondo me, molto pericoloso. Infatti, è certo che le foglie stesse disturbano lo spirito, se se ne prende più di quattro. (…) Si fa anche con il seme un olio che, instillato nell’orecchio, disturba l’intelligenza. Cosa singolare, sono stati indicati rimedi per coloro che avevano bevuto questo succo come fosse un veleno, e si è indicato questo succo stesso tra i rimedi: è così che si moltiplicano senza fine gli esperimenti, e si costringono perfino i veleni a diventare utili”[6].
Al tempo stesso veleno temibile e rimedio ricercato, ecco tutto il problema.
Recipiente o pipa?
L’interpretazione dell’oggetto di Houten-Castellum divide i ricercatori. L’ipotesi di una pipa per fumare i semi si basa sull’analisi del tappo di catrame, che mostra segni di riscaldamento irregolare, e su una menzione di Plinio secondo cui “il fumo di giusquiamo bruciato” può aiutare contro i dolori articolari[7].
Tuttavia, diversi elementi contradicono questa interpretazione: i semi ritrovati non sono carbonizzati, il loro numero importante sembra eccessivo per un utilizzo uso in quanto droga, e le pipe sono estremamente rare in Europa prima dell’arrivo del tabacco. L’ipotesi del recipiente di conservazione appare quindi più probabile. L’osso sarebbe servito a conservare i semi, un migliaio al massimo, chiuso in modo ermetico dal catrame.
Offerte misteriose
Il luogo della scoperta e tutto ciò che lo circonda lasciano pensare ad un uso deliberato del giusquiamo. L’osso pieno di semi era accompagnato da uno scheletro parziale di mucca e da altri oggetti insoliti: frammenti di macina, cranio di cane e scheletro incompleto di cavallo con tracce di macellazione. L’insieme è interpretato come un'”offerta di abbandono”, ovvero un deposito rituale che segna l’interruzione dell’uso del pozzo.
Una seconda scoperta sullo stesso sito rafforza questa ipotesi. In un fossato di recinto, gli archeologi hanno trovato un cesto rovesciato, quattro vasi da cucina e un’infiorescenza completa di giusquiamo nero, datati 90-110 dopo la nostra era. Questo insieme costituisce ugualmente un’offerta di abbandono.
La presenza di giusquiamo in due depositi rituali contemporanei non può essere casuale. Suggerisce che questa pianta rivestiva un’importanza particolare per gli abitanti di Houten-Castellum.
L’uso del giusquiamo nero a fini medicinali o rituali nell’Impero romano non è isolato. A Neuss (Germania), nell’ospedale della fortezza romana, 128 semi carbonizzati di giusquiamo nero sono stati trovati accanto ad altre piante medicinali: fieno greco, verbena, centaurea, iperico, aneto e coriandolo.
Oltre i confini dell’Impero
L’uso del giusquiamo nero oltrepassa i confini e il tempo dell’Impero romano.
Nella fortezza circolare di Fyrkat in Danimarca, verso il 980 dopo la nostra era, semi di questa pianta sono stati scoperti nella tomba di una donna, probabilmente in una borsa di cuoio, accompagnati da una “bacchetta” metallica e da una scatola contenente piccole ossa di animali. La donna era verosimilmente una völva, una veggente che utilizzava i semi a fini allucinatori.
Gli ospedali medievali di Scozia e Finlandia hanno ugualmente fornito semi di giusquiamo nero, testimoniando la continuità del suo uso medico.
L’osso di Houten-Castellum illustra così la varietà delle pratiche mediche e rituali nelle province romane. Lontano dai grandi centri urbani, gli abitanti di questa fattoria dei Paesi Bassi padroneggiavano le proprietà di una pianta che i medici di Roma e di Atene descrivevano nei loro trattati.
Una droga millenaria
L’uso del giusquiamo non inizia con i Romani. Le tavolette d’argilla di Sumer fanno già menzione dell’utilizzo del giusquiamo come allucinogeno. Il papiro Ebers, un papiro medico scritto a Tebe verso il 1600 prima della nostra era, menziona anche il giusquiamo tra centinaia di altre droghe (oppio, senna, ricino).
Il giusquiamo veniva utilizzato in combinazione con altre piante – mandragora, belladonna e datura – come pozione anestetica e per le sue proprietà psicoattive in bevande reputate magiche. I Greci conoscevano bene le sue proprietà deliranti. Conosciuta con il nome di Herba Apollinaris, era utilizzata dalle sacerdotesse di Apollo per rendere i loro oracoli. A Delfi, la pizia avrebbe, prima di procedere a qualsiasi divinazione, consumato un idromele a base di miele e giusquiamo. Utilizzava anche il fumo dei semi per ubriacarsi e profetizzare.
In Scandinavia, in una tomba risalente all’età del bronzo, è stata ritrovata una birra aromatizzata con diverse piante (mirto, olmaria), tra cui il giusquiamo nero. Questa aggiunta moltiplicava gli effetti dell’ebbrezza alcolica.
[1] Dioscoride, De Materia Medica 4.69: χρῆσθαι δεῖ τῷ λευκῷ· εἰ δὲ μὴ παρείη οὗτος, χρῆσθαι δεῖ τῷ ξανθῷ, τὸν δὲ μέλανα ἀποδοκιμάζειν ὡς χείριστον” et “ἑψηθέντα δὲ ὡς λάχανα καὶ βρωθέντα τρυβλίου πλῆθος μετρίαν παροκοπὴν ἐργάζεται.
[2] Plinio il Vecchio, Storia naturale, 25.17.35: omnia insaniam gignentia capitisque vertigines.
[3] Idem, 22.58.124: nervis cum hyoscyami suco inlinitur.
[4] Idem, 26.58.89: testium tumores sedat hyoscyamum.
[5] Idem, 20.73.193: similiter ad ventris aut intestinorum inflationes et orthopnoicis quod ternis digitis prenderet seminis, tantundem hyoscyami cum lacte asinino.
[6] Idem, 25.17.36-37: temeraria in totum, ut arbitror, medicina. quippe constat etiam foliis mentem corrumpi, si plura quam IIII bibant; etiam antiqui in vino, febrim depelli arbitrantes. oleum fit ex semine, ut diximus, quod ipsum auribus infusum temptat mentem, mireque, ut contra venenum, remedia prodidere iis, qui id bibissent, et ipsum pro remediis, adeo nullo omnia experiendi fine, ut cogant etiam venena prodesse.
[7] Idem, 26.15.27: nidor quoque accensi tussientibus.
Fonte
Questo articolo si basa sul saggio di L. I. Kooistra, M. Groot, L. Kubiak-Martens, E. Langer e J. van Renswoude, Evidence of the intentional use of black henbane (Hyoscyamus niger) in the Roman Netherlands, Antiquity, Cambridge University Press, 2024.
Altri articoli del blog Nunc est bibendum