Il Gioco del Passaggio
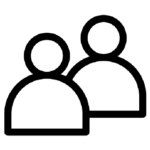 2 giocatori 2 giocatori |
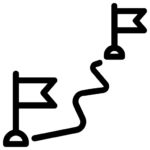 Percorso Percorso |
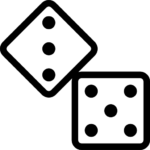 Caso Caso |
 Complesso Complesso |
 Lungo Lungo |
Storia

Il senet (dall’antico egizio znt, che significa «passare»; copto ⲥⲓⲛⲉ /sinə/, «passare, pomeriggio») è uno dei giochi da tavolo più antichi conosciuti, con una storia documentata di oltre 5000 anni. Tavole simili sono state scoperte in sepolture predinastiche e della I dinastia (3500-3100 a.C.) ad Abydos e Saqqara. La prima rappresentazione certa risale a circa il 2620 a.C., nella mastaba di Hesy-Ra, alto funzionario della III dinastia sotto il re Djoser.
Evoluzione dal gioco secolare al rituale mistico
Antico e Medio Regno (circa 2686-1650 a.C.). Durante l’Antico Regno, il senet è esclusivamente un passatempo. Le rappresentazioni tombali, come quella di Pepi-ankh a Meir (circa 2300 a.C.), mostrano giocatori che si affrontano con commenti strategici rivelando un gioco di posizione dove gli esperti potevano far passare le loro sette pedine davanti a quelle dell’avversario. Il movimento si effettua in bustrofedico (direzione invertita a ogni fila), caratteristica unica del senet. Le ultime cinque caselle portano iscrizioni secolari: «buono», «cattivo», e la sequenza 3-2-1, che determina i movimenti di uscita e non cambierà mai in 3000 anni.
Nuovo Regno: la trasformazione religiosa (XVIII dinastia, 1570-1293 a.C.). Questo periodo segna una rivoluzione completa. Il gioco passa da sette a cinque pedine per giocatore e si integra in scatole di legno con cassetto, spesso fabbricate specificamente per le tombe con la formula di offerta funeraria iscritta. Più fondamentalmente, sotto Hatshepsut (circa 1498 a.C.), la sequenza 3-2-1 diventa tre uccelli, due uomini, un uomo, mentre il «cattivo» si trasforma in trappola acquatica. Sotto Seti I (1291-1279 a.C.), gli «uomini» diventano «dei».
Le rappresentazioni tombali evolvono radicalmente: il senet scompare dalle scene quotidiane per apparire in un contesto religioso, spesso legato al Libro dei Morti. I giocatori non si affrontano più tra loro ma contro un avversario invisibile – la propria anima.
La cartografia dell’aldilà
Alla fine della XVIII dinastia (1293 a.C.), la tavola diventa una vera simulazione del viaggio notturno con il dio Ra attraverso le 12 regioni dell’aldilà (corrispondenti alle 12 ore della notte). Ogni casella corrisponde a divinità ed eventi specifici: la casella 1 «Casa di Thot» annuncia l’arrivo del defunto al tribunale divino; la casella 12 rappresenta la costellazione di Orione/Osiride; la casella 15 «Casa della Vita che si Ripete» (rana, simbolo di resurrezione) offre un turno supplementare; la casella 27 «Acque del Caos» costituisce la trappola definitiva dove le pedine sono definitivamente perdute, come le anime peccatrici annegate nelle acque primordiali.
La casella finale (30) di Ra-Horakhty rappresenta il dio solare sotto la sua forma di sole nascente all’alba. Farvi passare tutte le proprie pedine significa realizzare l’unione mistica con il dio solare da vivi, garantendo la sopravvivenza alle prove dell’aldilà prima ancora di morire. Questa scoperta rivela che gli Egizi credevano di poter influenzare attivamente il giudizio della loro anima – una credenza rivelata dalle ricerche di Peter Piccione.
Bassa Epoca (XX dinastia, circa 1185-1075 a.C.). L’evoluzione religiosa raggiunge il suo apogeo con tavole interamente decorate di motivi religiosi, accompagnate da testi rituali dove il giocatore narra in prima persona il viaggio delle sue pedine attraverso l’aldilà. Paradossalmente, forme secolari persistono simultaneamente, testimoniando la coesistenza notevole di due tradizioni: il gioco ricreativo e la sua versione mistica.
Espansione e declino
Il senet si espande oltre l’Egitto, in particolare a Cipro verso la fine del terzo millennio, testimoniando l’influenza culturale egizia. Nonostante 3000 anni di evoluzione, il gioco conserva una notevole stabilità strutturale.
Il declino inizia durante il periodo romano, benché graffiti a Dendera suggeriscano una persistenza residuale. Il gioco sopravvive anche nella letteratura tardiva: nel racconto Setne Khamwas e Si-Osiride (epoca romana), il defunto Naneferkaptah sfida Setne a un gioco da tavolo per un libro misterioso. Benché il senet non sia nominato, la posta in gioco mistica, il contesto funerario e le implicazioni religiose della sfida evocano chiaramente questo gioco, testimoniando la sua persistenza nell’immaginario egizio.
Le regole esatte non ci sono pervenute, ma diverse ricostruzioni sono state proposte a partire dai lavori pionieristici di Gustave Jéquier negli anni 1930.
Regole del gioco
Materiale e preparazione
- Una tavola da gioco la cui superficie è divisa in 30 caselle disposte in tre file parallele di 10 caselle. Le 15ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª e 30ª caselle sono ornate da un disegno e hanno significati particolari.
- 2 serie di colori o forme diverse di 7 pedine, ovvero 7 pedine identiche per giocatore (Nel Nuovo Regno, sembra che il gioco si pratichi preferibilmente con 5 pedine per giocatore).
- 4 bastoncini con una faccia decorata (o dipinta di un certo colore) e una faccia «neutra» (colore naturale o dipinta di un altro colore).
Le pedine sono disposte sulle prime 14 caselle del gioco in modo alternato: le pedine di un colore sulle caselle dispari, le pedine dell’altro colore sulle caselle pari.
 La casella contrassegnata dal segno di vita ankh (15ª casella) è la casella di partenza.
La casella contrassegnata dal segno di vita ankh (15ª casella) è la casella di partenza.
Scopo del gioco
Far percorrere a tutte le proprie pedine un itinerario dato, poi farle uscire dal gioco, cercando allo stesso tempo di rallentare la progressione delle pedine avversarie. Il primo giocatore che riesce a far uscire tutte le sue pedine dal gioco vince la partita.
Movimento delle pedine
Le pedine avanzano nel gioco seguendo un percorso a forma di S rovesciata (da destra a sinistra sulla prima fila, poi da sinistra a destra sulla seconda e infine di nuovo da destra a sinistra sull’ultima).

Il movimento delle pedine avviene sempre in avanti e secondo le indicazioni fornite dal lancio simultaneo, in aria, dei quattro bastoncini di cui si esamina la combinazione una volta ricaduti. Le facce rivolte verso l’alto vengono considerate come segue:
- Una superficie decorata: 1 punto e si gioca di nuovo
- Due superfici decorate: 2 punti e si passa il turno
- Tre superfici decorate: 3 punti e si passa il turno
- Quattro superfici decorate: 4 punti e si gioca di nuovo
- Quattro superfici «neutre»: 5 punti e si gioca di nuovo
Il numero di punti ottenuto può essere utilizzato con qualsiasi pedina del proprio colore, ma non può essere ripartito tra più pedine.
È permesso saltare sopra le pedine (proprie o avversarie), tranne quando tre pedine avversarie occupano caselle contigue (vedi sotto). Le caselle occupate contano anche nel numero di punti di avanzamento.
Due pedine, anche se dello stesso colore, non possono mai occupare la stessa casella.
Far arretrare l’avversario
Una pedina non può mai essere rimossa dal gioco. Non ci sono quindi catture di pedine avversarie, ma si può far arretrare il proprio avversario: quando una pedina finisce su una casella occupata da una pedina avversaria, quest’ultima deve arretrare fino alla casella da cui proveniva l’attaccante (le pedine si scambiano quindi le posizioni).
Due pedine dello stesso colore in due caselle contigue formano un piccolo blocco: sono inattaccabili. Il giocatore avversario non può quindi farle arretrare e prendere uno di questi due posti. Deve allora spostare un’altra delle sue pedine o, se è impossibile, rimanere fermo e passare il turno.
Tre pedine dello stesso colore che si susseguono formano un grande blocco; non solo si proteggono a vicenda, ma inoltre non possono essere superate da una pedina avversaria. Formano quindi un muro per l’avversario (senza però impedire alle pedine del proprio schieramento di avanzare).
Questa situazione di blocco è una delle basi tattiche del gioco, obbligando il giocatore a far arretrare una delle sue pedine se non può farne avanzare nessun’altra (questo gioco di scambi di posizioni e di blocco può già effettuarsi dietro la casella di partenza, prima ancora che le pedine siano impegnate nel percorso).
Svolgimento della partita

I giocatori lanciano alternativamente i bastoncini. Chi ottiene un lancio di «1» inizia. Sposta la pedina posizionata sulla 14ª casella verso la casella di partenza ankh e prende quindi le pedine del colore di questa pedina.
La sosta sulla casella di partenza ankh è obbligatoria. Ogni pedina deve quindi, con uno o più lanci dei bastoncini, finire sulla casella di partenza prima di poter iniziare il percorso. Questa casella è protetta, la pedina non può quindi esserne sloggiata dall’avversario. Rimanendo su questa casella, una pedina può quindi bloccare l’entrata in gioco delle altre pedine.
Successivamente, il lancio dei bastoncini indica il numero di punti di avanzamento che il giocatore può attribuire a una delle sue pedine a scelta.
Finché un giocatore ottiene un «1», un «4» o un «5», può giocare di nuovo, ma appena ottiene un «2» o un «3», gioca e passa il turno al suo avversario.
I giocatori fanno avanzare le loro pedine a turno, secondo il numero di punti ottenuti, cercando di superare quelle dell’avversario mentre tentano di bloccarlo o di farlo arretrare.
Se un giocatore non può eseguire il numero di punti ottenuti dal lancio dei bastoncini, deve farlo all’indietro. Ogni mossa che non permette di avanzare deve essere utilizzata per arretrare di altrettante caselle, purché finisca così su una casella che non occupa già.
Se, in questo modo, si finisce su una pedina avversaria, bisogna spostarla (e quindi farla avanzare) fino alla casella da cui proveniva.
Se, nonostante questo, nessun movimento è possibile, il giocatore passa il suo turno.
Caselle speciali alla fine del percorso
 Casella «Casa della Felicità» (26ª), contrassegnata nefer («buono»), è una casella «fortuna» dove la pedina è inattaccabile. Un lancio di «5» permette alla pedina di uscire immediatamente dal gioco. Con un lancio di «1», il giocatore ha il diritto di rilanciare i bastoncini (per non finire sulla casella «Casa dell’Acqua»).
Casella «Casa della Felicità» (26ª), contrassegnata nefer («buono»), è una casella «fortuna» dove la pedina è inattaccabile. Un lancio di «5» permette alla pedina di uscire immediatamente dal gioco. Con un lancio di «1», il giocatore ha il diritto di rilanciare i bastoncini (per non finire sulla casella «Casa dell’Acqua»).
 Casella «Casa dell’Acqua» (27ª), contrassegnata dal segno mu («acqua»), è una trappola: ogni pedina che finisce in questa casella sarà rimandata alla casella di partenza ankh: la «Casa della Rinascita» o, se questa è occupata, alla prima casella vuota prima della casella «partenza». Il giocatore può anche scegliere di rimanere in questa casella fino a quando un lancio di «4» gli permetta di uscire dal gioco. Tuttavia, gli è allora vietato spostare un’altra delle sue pedine sulla tavola.
Casella «Casa dell’Acqua» (27ª), contrassegnata dal segno mu («acqua»), è una trappola: ogni pedina che finisce in questa casella sarà rimandata alla casella di partenza ankh: la «Casa della Rinascita» o, se questa è occupata, alla prima casella vuota prima della casella «partenza». Il giocatore può anche scegliere di rimanere in questa casella fino a quando un lancio di «4» gli permetta di uscire dal gioco. Tuttavia, gli è allora vietato spostare un’altra delle sue pedine sulla tavola.
 Casella «Casa delle Tre Verità» (28ª), comporta simbolicamente il numero 3: solo un lancio di «3» permette di far uscire la pedina dal gioco.
Casella «Casa delle Tre Verità» (28ª), comporta simbolicamente il numero 3: solo un lancio di «3» permette di far uscire la pedina dal gioco.
 Casella «Casa di Ra-Atum» (29ª), comporta simbolicamente il numero 2: solo un lancio di «2» permette di far uscire la pedina dal gioco.
Casella «Casa di Ra-Atum» (29ª), comporta simbolicamente il numero 2: solo un lancio di «2» permette di far uscire la pedina dal gioco.
 Casella «Casa di Horus» (30ª): solo un lancio di «1» permette di far uscire la pedina dal gioco.
Casella «Casa di Horus» (30ª): solo un lancio di «1» permette di far uscire la pedina dal gioco.
Inoltre, le caselle «Felicità», «Tre Verità» e «Ra-Atum» proteggono le pedine che ospitano; non possono essere attaccate, anche se sono isolate, e possono rimanerci senza limite di tempo.
Per saperne di più
- C. Breyer, Jeux et jouets à travers les âges. Histoire et règles de jeux égyptiens, antiques et médiévaux, Bruxelles, éditions Safran, 2010.
- P. Piccione, In Search of the Meaning of Senet, 1980
- Articolo Senet, su Wikipedia.
- Esperienza pedagogica che utilizza il senet per insegnare le probabilità, descritta in un articolo dell’Istituto di ricerca sull’insegnamento della matematica (IREM) di Lille: Le senet, de l’Egypte ancienne à nos cours de mathématiques, François Martini, Lisa Rougetet, gennaio 2019.
Ritorna alla pagina principale sui giochi da tavolo antichi